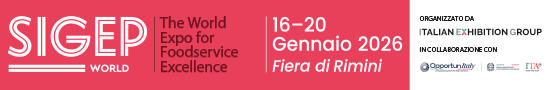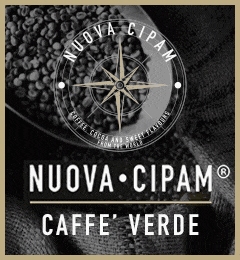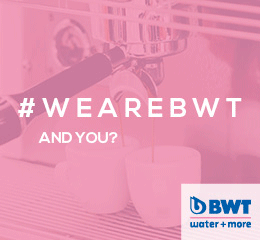Condividi con noi le tue storie legate al caffè scrivendo a direzione@comunicaffe.it.
MILANO – L’annosa questione del cupping score, croce e delizia di molti lungo la filiera, a partire dai contadini sino ad arrivare a chi quel caffè lo importa, lo seleziona, lo tosta, lo estrae, è difficile da districare. Soprattutto ora che il sistema di valutazione sta piano piano modificandosi per restare attuale, complice anche la svolta del Coffee Value Assessment (CVA).
Si resta intrinsecamente legati al tema dell’oggettività: chi valuta, il modo in cui lo fa, rende davvero possibile attribuire un punteggio che definisca univocamente la qualità della materia prima, senza essere influenzato da molti fattori? Nella maggior parte dei casi si tratta di bias culturali, ambientali, se non persino individuali, e in altri invece si tratta di vero e proprio pointwashing – ovvero un modo di gonfiare il prezzo di un prodotto, vendendolo ad un punteggio eccessivamente stimato -.
Cercando di andare oltre il pointwashing, per tentare di sciogliere la matassa, arriva in aiuto dei lettori Deborah Righeschi, professionista di riferimento nel settore e responsabile per la qualità in NKG Bero Italia, che sicuramente di analisi sensoriale e di qualità si intende sul piano professionale.
La discussione sembra dover partire da una premessa, ovvero, il fatto che affidarsi ad un punteggio è stato per anni l’unico metro di paragone per stabilire il valore di un determinato caffè, con l’obiettivo di rendere il più oggettivo possibile l’analisi qualitativa.
Un’operazione che però inevitabilmente è guidata: “Quando descrivo il caffè con delle note di frutta gialla, per me significa pesca, per esempio ma per un assaggiatore brasiliano è sinonimo di ananas. È evidente qui che l’impatto culturale, il contesto, sono imprescindibili nella valutazione” specifica Deborah Righeschi.
Ma ora che con il CVA si tenta di allargare gli orizzonti analitici, includendo nuovi dettagli che probabilmente oggi il mercato o il consumatore finale richiedono maggiormente, le carte in tavola si complicano: entrano in gioco altri parametri come, ad esempio, il progetto di sostenibilità dietro la filiera, la storia del produttore, la tracciabilità. E così passa un po’ in secondo piano il punteggio a sé stante, con una conseguente limitazione della soggettività del cup taster.
E in qualche modo si riduce anche il rischio di imbattersi nel pointwashing.
Fenomeno che nasce come forma di speculazione per tentare di vendere a costi più alti il sia il caffè verde che il caffè tostato, riportando punteggi magari più elevati di quello che effettivamente valgono.
Specifica Deborah Righeschi: “Nell’atto pratico, il cupping score, viene attribuito internamente, scollegandosi dal format codificato da SCA che richiede di sottoporre il campione al CQI che a sua volta si occupa di inviarlo a 3 Q grader certificati, in 3 punti diversi del mondo, incrociando la loro valutazione proprio per conferire un punteggio finale il più condiviso possibile. Tuttavia, nella realtà dei fatti purtroppo, spesso le aziende non rispettano tutti questi passaggi.”
Ma la qualità, in effetti, poi che cos’è, se non qualcosa che viene determinato da chi valuta, innanzitutto. Ad esempio, un produttore che assaggia il suo prodotto, analizzerà la tazza in base a determinati elementi, come la fermentazione (se è andata bene o meno) o sulla raccolta (se è stata omogenea).
Mentre chi degusta dall’altra parte del mondo, darà un risultato differente, influenzato a sua volta dalla cultura, dall’esperienza soggettiva, dagli attributi qualitativi che può capitare non siano condivisi tra le due parti della filiera. Ci sono tanti fattori che influenzano questo concetto, che è composito e complesso.
A questo punto è legittimo porsi una domanda cruciale: è davvero auspicabile perseguire l’oggettività nella valutazione della qualità?
Questa riflessione rappresenta, forse, il fulcro del dibattito. Infatti, applicare un concetto rigorosamente oggettivo all’interno di un mercato complesso e dinamico, dove bisogni, aspettative e preferenze variano sensibilmente in base agli attori coinvolti e ai contesti socio-culturali di riferimento, impone una sfida importante: quella di conciliare standard tecnici con gusti individuali.
Su questo tema interviene con grande chiarezza e competenza Deborah Righeschi. Con un approccio tecnico e consolidato da anni di esperienza sul campo, afferma:
“Come NKG Bero Italia, ci impegniamo quotidianamente a mantenere un approccio oggettivo, lavorando per garantire il massimo allineamento tra le specifiche qualitative definite nei contratti e le caratteristiche effettive che emergono in tazza. Questo significa, in termini concreti, assicurare la coerenza qualitativa del prodotto nel tempo, che è uno degli elementi chiave nella gestione della materia prima.”
Righeschi mette anche in luce un aspetto fondamentale del sistema di valutazione:
“Posso attribuire un punteggio di 95 a uno specialty coffee sulla base di parametri il più possibile oggettivi e standardizzati, ma ciò non implica che il consumatore finale percepisca la stessa eccellenza. Io opero secondo criteri professionali e tecnici, lasciando da parte i miei gusti personali; al contrario, il consumatore valuta il caffè secondo le proprie preferenze sensoriali, ovvero in modo soggettivo.”
Questa considerazione evidenzia un punto spesso trascurato: in ultima analisi, è il consumatore finale ad assegnare il “vero punteggio” al prodotto. È lui, con le sue scelte di acquisto, a sancire il valore di mercato di un caffè. Si potrebbe quasi affermare che il consumatore finale è il vero Q Grader.
Di fronte a queste premesse, il sistema del punteggio può ancora reggere?
La risposta di Deborah Righeschi è un ottimo spunto di riflessione: “A livello di caffè specialty sì, potrebbe ancora reggere nell’immediato futuro, perché comunque facilita la transazione commerciale a qualsiasi livello, in quanto riferimento quantitativo di un valore qualitativo. Quindi sembra difficile che venga del tutto abbandonato, quantomeno nel breve periodo.
Certo, con l’entrata a gamba tesa del CVA, e la rivoluzione per quanto riguarda il nuovo corso Q-grader (che faceva capo al CQI e che passa in seno alla SCA) che adotterà come sistema di valutazione il CVA al posto del vecchio cupping form incentrato sull’attribuzione del punteggio, probabilmente si verificherà una limitazione del mero punteggio in favore degli attributi.
Viceversa, per quanto riguarda lo scouting, nelle ricerche di mercato, ad esempio, sarà uno strumento molto utile per capire quanto è desiderabile il prodotto dai consumatori: in questo caso specifico il CVA potrebbe prendere il sopravvento nella valutazione dell’offerta. Difficilmente però, chi si occupa come NGK Bero Italia direttamente del controllo qualità della materia prima, si appoggerà al CVA.
Il nostro team, così come avviene in tutte le aziende che hanno un dipartimento qualità strutturato, si affida a delle procedure basate sulla valutazione delle caratteristiche qualitative definite contrattualmente per le specifiche preparazioni.
NKG Bero Italia ha dei parametri da rispettare come standard qualitativi. Ecco un esempio rappresentativo: Brasile, New York 2/3, 17/18, strictly soft, fine cup. In questa sigla c’è scritta tutta la specifica qualitativa che il lotto deve possedere. Quindi, Nello specifico, un numero specifico di chicchi difettosi su 300 grammi, secondo una scala internazionalmente riconosciuta, la New York Stock Exchange, per la valutazione del caffè brasiliano.
Viene definita, altresì, la grandezza del crivello, specificando 17/18 e il profilo di tazza desiderato che è strictly soft, fine cup, vale a dire una tazza estremamente morbida e dolce in generale, con buona corposità, bassissima acidità e uniforme su tutte e 5 le tazze in cui ogni singola partita viene assaggiata.
Ogni ente che si occupa di controllo di qualità, ogni trader o importatore o torrefattore, ha le proprie procedure interne di valutazione.”
Il pointwashing: fenomeno diffuso più all’origine o a valle della filiera?
La questione è tutt’altro che secondaria. Il fenomeno del pointwashing, ovvero l’assegnazione di punteggi di qualità gonfiati attribuiti al caffè, è diventato negli anni oggetto di attenzione crescente nel settore specialty. Ma dove si concentra maggiormente questo rischio? All’origine, nei Paesi produttori, o a valle, nei mercati importatori?
A chiarire il quadro interviene con lucidità Deborah Righeschi, la sua analisi, basata su un’esperienza diretta quotidiana, offre spunti fondamentali per comprendere le dinamiche reali dietro i numeri.
“Nei Paesi esportatori, dove spesso manca un accesso diretto ad altri caffè provenienti da diversi Paesi produttori, le possibilità di confronto sono molto limitate. Questo implica che le valutazioni qualitative si basino su un orizzonte ristretto, con il rischio di attribuire punteggi alti che, se confrontati con caffè di altre origini, non risultano coerenti. Diversamente, chi importa ha una visione più ampia e può raffrontare campioni da tutto il mondo, disponendo così di un metro di giudizio più oggettivo.”
Righeschi sottolinea anche come, in alcuni casi, l’interesse commerciale possa incidere direttamente sulla valutazione:
“Chi ha interesse nella vendita può essere portato ad attribuire punteggi elevati, anche in modo non del tutto trasparente, con l’obiettivo di ottenere un prezzo più alto. Tuttavia, quando quel caffè arriva da noi, viene sempre assaggiato nuovamente: questo ci permette di mettere in discussione il punteggio iniziale e di esprimere una valutazione più equilibrata.”
In un contesto dove la soggettività è parte integrante del processo valutativo, emerge un concetto chiave:
“Oggi, più che il numero riportato in etichetta, è diventato fondamentale sapere chi ha assegnato quel punteggio. La credibilità e la competenza del valutatore sono ormai una garanzia molto più affidabile della cifra stessa.”
Un altro elemento da considerare riguarda il mercato di riferimento. In Italia, il segmento dei consumatori truly specialty è ancora molto contenuto. Come conferma Righeschi: “Nel nostro mercato, il consumatore di caffè specialty è ancora una nicchia. All’estero, invece, si sta osservando un’evoluzione: il dato numerico comincia a perdere centralità sulle etichette, lasciando spazio ad altre forme di comunicazione della qualità.
Data l’evoluzione del mercato, statistiche e trend confermano che nei paesi con consumatori più abituati allo specialty (es. USA, UK, Germania, Nord Europa) si tende a differenziare sempre di più la comunicazione della qualità: oltre al punteggio, emergono storytelling, etica, origini e sostenibilità.
Infine, si affaccia all’orizzonte un possibile cambiamento legato all’introduzione del CVA, il nuovo sistema promosso da SCA:
“È ancora prematuro valutarne l’impatto effettivo, visto che è stato introdotto di recente. Ma la sua progressiva integrazione nella formazione SCA e nei percorsi Q Grader potrebbe accelerare l’evoluzione del sistema di valutazione nel suo complesso.”
In definitiva, il punto sollevato da Righeschi evidenzia come la professionalità e la trasparenza nella filiera siano strumenti essenziali per garantire credibilità al sistema di punteggi. In un settore sempre più attento alla qualità percepita e reale, sapere da chi arriva il giudizio è diventato parte integrante del valore del caffè stesso.