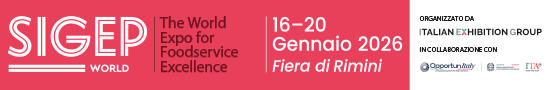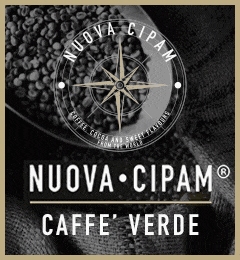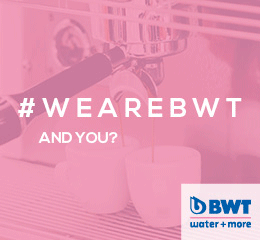Condividi con noi le tue storie legate al caffè scrivendo a direzione@comunicaffe.it.
TORINO – La parola al dottor Luca Raimondo, Direttore dell’U.O. di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Humanitas Gradenigo e Responsabile del Centro di diagnosi e cura per i disturbi dell’olfatto e del gusto della medesima struttura, che ha diretto il corso di formazione “Olfatto e Gusto a 360°. Dalla fisiopatologia al loro ruolo nel quotidiano” con la presenza del professor Thomas Hummel, Direttore della “Smell and Taste Cinic” del Dipartimento di Otorinolaringoiatria dell’Università di Dresda e il professor Giancarlo Pecorari, ordinario di Otorinolaringoiatria presso l’Università di Torino.
Questa è stata anche l’occasione di organizzare i coffee break con la guida di Fabio Verona, Responsabile formazione ed eventi presso Caffè Costadoro, che ha reso l’esperienza sensoriale completa e interattiva.
Raimondo, ma come è nata la connessione tra il mondo della medicina e quella del professionista del caffè e quindi tra lei e Fabio Verona?
“Innanzitutto il mondo della medicina e quello del caffè hanno un territorio in comune: trattandosi di una bevanda energizzante contenente caffeina, molecola che ha noti effetti sul sistema nervoso centrale e su quello cardiovascolare, la connessione viene naturale. Si è parlato molto quindi di un suo ruolo sulla salute dell’individuo.
Ci si potrebbe chiedere piuttosto: ma l’otorino che cosa c’entra? La risposta in realtà è piuttosto semplice: nel mondo del caffè è di fondamentale importanza analizzare con olfatto e gusto, le caratteristiche della materia prima, dalla tostatura all’estrazione e degustazione in tazza.
Ciò che mi ha portato a contattare Fabio Verona è stato proprio questo: i professionisti del caffè, utilizzano i due sensi con cui io lavoro quotidianamente e così l’ho voluto coinvolgere nella realizzazione del Congresso che abbiamo tenuto a Torino.
Perché tengo a sottolineare che sono i sensi con cui lavora un otorino? Olfatto e gusto sono stati un po’ sottovalutati nel corso degli anni. Fatta eccezione per alcuni centri Europei e Statunitensi che se ne sono occupati, in Italia è soltanto di recente, un po’ spinti dalla pandemia e un po’ per l’avvento di terapie specifiche quali gli anticorpi monoclonali per il trattamento della poliposi nasale recidiva, che l’olfatto ha ripreso una rilevanza clinica.
Lo studio del gusto è invece ancora appannaggio di sporadici centri specializzati come il nostro.”
Ci racconta brevemente le modalità e i criteri (quali attrezzature e quali caffè sono stati proposti) con cui si è svolto l’esperienza che avete portato avanti insieme a Torino?
“Il Congresso è stato, a livello nazionale, il primo evento focalizzato totalmente sulla patologia olfattiva, ma anche sul ruolo dell’olfatto nella quotidianità della nostra società e da qui deriva il titolo stesso dell’incontro.
Dopo una prima parte caratterizzata dalla presentazione delle relazioni scientifiche che ha visto coinvolti parecchi medici, è arrivato il turno di Fabio Verona e Matteo Sperandio di De’Longhi che hanno reso interattivo e didattico il momento del coffee break. In queste pause abbiamo condiviso prima di tutto una parte teorica per spiegare concetti non così noti al pubblico più ampio e abbiamo fatto comprendere il ruolo dei due sensi nel mondo del caffè.
In seguito si è passati alla pratica: la seconda parte della pausa caffè è stata appunto strutturata con l’allestimento di un certo numero di isole, ciascuna dotata di una Rivelia De’Longhi gestita dai ragazzi della Scuola Immaginazione e Lavoro di Torino che assistevano i partecipanti, seguendo le istruzioni di Fabio Verona. È stata servita una prima tipologia di espresso, si ragionava insieme su questa e poi veniva proposta una seconda per poter fare un confronto.
Questo è stato un modo per traslare nel gesto quotidiano del caffè, le notizie, le informazioni che avevamo appreso durante la didattica frontale. È stato molto apprezzato dai Colleghi, perché ha acceso una lampadina su aspetti sensoriali e tecnici che stanno dietro e dentro ad una tazzina di caffè che spesso non si conoscono: ancora oggi, a mesi di distanza dal Congresso, i colleghi ricordano con piacere proprio i coffee break.
Non possiamo pensare di medicalizzare l’analisi sensoriale del caffè, così come di molti altri prodotti del settore eno-gastronomico, ma sicuramente lo spiegare in modo corretto e semplice come funzionano i due sensi che la rendono possibile risulta interessante, diventa poi doveroso, se l’analisi sensoriale è condotta da professionisti per valutare ed eventualmente premiare le caratteristiche organolettiche di un prodotto.
Spesso si sentono utilizzare termini impropri o concetti desueti nell’insegnare l’analisi sensoriale: vediamo due esempi semplici.
Il primo è relativo all’utilizzo dell’espressione “al palato”: il palato è una struttura anatomica che nulla ha a che vedere con le percezioni gustative o olfattive retronasali, basterebbe dire “in bocca” e sarebbe già subito più corretto; il secondo esempio è invece legato alla percezione dei gusti: si sente ancora dire che la capacità di percepire dolce, salato, acido e amaro varia da un’area della lingua ad un’altra quando invece sono decenni che sappiamo che tutta la superficie linguale percepisce allo stesso modo tutti i gusti.
Quanto incide l’olfatto e quanto il gusto, nella valutazione della qualità di un caffè?
“Tra i due caffè assaggiati, uno era di un livello inferiore rispetto all’altro. Va da sé che, senza l’olfatto e il gusto, non si può dare una valutazione qualitativa della bevanda. I sensi entrano a gamba tesa nell’analisi organolettica nel caffè estratto, quindi, chi nel settore del caffè, ma anche in quello del vino, dell’olio o dei formaggi, si occupa di valutare la qualità del prodotto, deve avere una capacità olfattiva e gustativa integra ed allenata, in modo da poter percepire al meglio le caratteristiche organolettiche di ciò che sta valutando.
Quando vengono creati dei panel di assaggiatori, bisognerebbe pertanto essere certi che, nella loro composizione, rientrino persone senza alterazioni patologiche della capacità olfattiva e gustativa che possano pregiudicare la loro abilità analitica.
Obiettivo, questo, facile da raggiungere grazie alla disponibilità, di test rapidi di screening che permettono di classificare la persona come dotata di una capacità olfattiva e gustativa normale piuttosto che potenzialmente compromessa, in quest’ultimo caso sono poi necessari ulteriori approfondimenti per confermare o sconfessare il dato dei test di screening.
Come funziona scientificamente, l’assaggio usando questi due sensi?
“Quando assaporiamo un cibo o una bevanda innanzitutto dobbiamo distinguere le sensazioni olfattive da quelle gustative. Quando parliamo di sensazioni olfattive intendiamo sia quelle derivanti dalla via ortonasale (odoro qualcosa senza introdurlo in bocca) che da quella retronasale (colgo le sfumature aromatiche di cibi e bevande dopo averle introdotte in bocca).
Le molecole olfattive raggiungono i recettori presenti in una specifica area del nostro naso e li vengono convertite in una “mappa elettrica” che, tramite i filuzzi, i bulbi e i nervi olfattivi olfattivi, raggiunge la corteccia olfattoria la quale invia ed integra informazioni con altre aree del cervello sede della memoria, delle emozioni, delle integrazioni sensoriali etc…
L’olfatto, il nostro senso più antico e continuamente utilizzato nell’arco di tutta la vita, è veicolato al cervello da una via molto breve e diretta in grado di elicitare ricordi, emozioni e sensazioni in tempi molto rapidi, ecco pertanto che quando entriamo in una stanza e riconosciamo un determinato odore, nell’arco di qualche millisecondo lo identifichiamo e poi lo associamo a dei ricordi, a delle sensazioni piacevoli o meno.
Assaporare un cibo vuol però anche dire gustarlo, ossia riconoscere le sue caratteristiche gustative. Ecco che qui abitualmente si genera la confusione. E per cercare di chiarire questo punto è necessario precisare che i gusti sono: dolce, salato, acido, amaro, umami e il “neonato” oleogusto.
Essi sono percepiti su tutto l’ambito linguale da apposite strutture recettoriali che convertono la molecola gustativa in un impulso elettrico che, analogamente a quanto accade per tutti gli altri sensi, viene inviato alle strutture corticali deputate tramite una via che, se paragonata con quella olfattiva, è più lunga e meno rapida, ma soprattutto meno evocativa.
Dalla integrazione delle informazioni olfattive e gustative si genera poi il sapore di un cibo o di una bevanda, dobbiamo pertanto essere attenti nel dire che la lasagna ha un sapore caratteristico, mentre dire che ha un gusto caratteristico è errato.”
Quanto influenza il contesto, l’esperienza individuale, nell’interpretazione di quello che viene raccolto poi con naso e bocca?
“La memoria ci permette di riconoscere un qualcosa con cui siamo già venuti a contatto in precedenza. Il cervello, ogni volta che ci si trova di fronte ad uno stimolo olfatto-gustativo, è in grado di rievocare quanto appreso in passato e di riportarlo a galla permettendo così il riconoscimento degli stimoli stessi. Un esempio: tutti conosciamo il profumo del limone.
Se in una stanza si immettesse questo aroma, lo riconosceremmo senza vederlo e lo sapremmo descrivere. La memoria viene stimolata, individua il sentore e fa riemergere tutta una serie di informazioni riguardanti questo frutto. Viene da se che non saremo mai in grado di identificare e ricordare stimoli con i quali non siamo mai venuti a contatto.
Assaporare molto è pertanto fondamentale per sviluppare la nostra capacità di riconoscere ma … non basta!!
La capacità olfattiva, come quella gustativa sono geneticamente determinate, pertanto esse differiscono da soggetto a soggetto, pensiamo per esempio al betaionone, molecola responsabile della percezione dell’aroma della violetta, esso non viene percepito da circa il 50% della popolazione, pertanto se in un vino esso è presente non è detto che venga percepito: anche il sommelier più bravo al mondo, se non possiede il corredo genetico atto a codificare il recettore per il betaionone, non lo percepirà.
Nei corsi in cui si insegna l’analisi sensoriale di cibi e bevande, bisognerebbe essere consapevoli di questo impatto della genetica e onesti nel dire che chi non ha determinate percezioni olfattive e gustative non sta sbagliando, ma semplicemente non ha l’ “hardware” per poterle percepire.”
Quali sono le differenze principali tra chi usa olfatto e gusto in maniera professionale e un consumatore non allenato? Quanto è questione di genetica e quanto di abitudine?
“Come dicevamo prima, la genetica gioca un ruolo importante e nulla si può fare per modificarla, discorso questo che vale sia per i professionisti che per i non professionisti. La differenza fra queste due categorie è invece abissale, ma colmabile, in termini di allenamento a riconoscere.
Un professionista che fa analisi sensoriale è entrato a contatto, allenandosi, con un numero sicuramente maggiore di odoranti rispetto ad un normale consumatore il quale però, a sua volta, con un opportuno training, può raggiungere i livelli di un professionista: non dimentichiamoci che professionisti non si nasce, si diventa.”
A proposito di olfatto, ormai è realtà l’esistenza di un naso elettronico: lei cosa ne pensa? C’è un futuro applicabile di questo strumento nel campo dell’assaggio?
“Quando parliamo di metodiche per l’analisi della componente aromatica di un campione dobbiamo citare innanzitutto la gas-cromatografia, si tratta di una metodica oggettiva e inoppugnabile che ci restituisce l’elenco di tutte le molecole aromatiche presenti in varia quantità in un campione di aria, tuttavia il suo risultato non è minimamente da comparare con la sensazione olfattiva che il nostro grado è in grado di generare, analogo discorso è da fare anche per il naso elettronico, altra metodica oggettiva ma nettamente meno fine e precisa della precedente.
Nessuna macchina per il momento è in grado di mimare quello che fa il nostro naso, tuttavia per i pazienti anosmici, con una condizione olfattiva così compromessa che non sono in grado di svolgere tutta una serie di operazioni quotidiane (identificare il cibo avariato, godere delle meraviglie enogastronomiche, profumeria, igiene personale) si sta facendo molta ricerca per tentare di creare “protesi olfattorie”, nasi artificiali sostitutivi, in grado di vicariare l’olfatto venuto meno ma è un percorso molto complesso e ostico.
Sulla futura applicabilità del naso elettronico nel campo dell’assaggio non mi esprimo perché si allontana troppo dal campo della medicina e non vorrei essere né disfattista né troppo possibilista.”