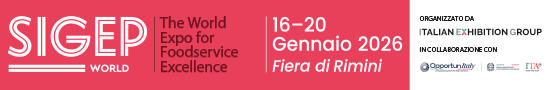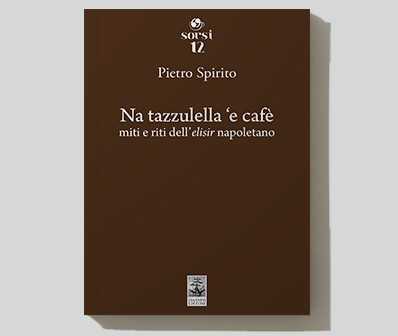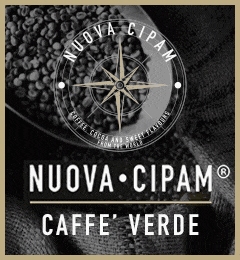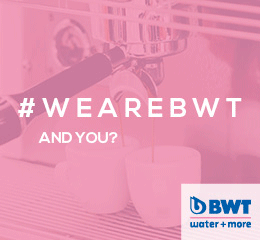Condividi con noi le tue storie legate al caffè scrivendo a direzione@comunicaffe.it.
MILANO – C’è chi lo ama e chi lo critica, ma è certo che nel mondo il caffè napoletano è un simbolo di un modo di gustarsi l’espresso. Si parla di una storia che si perde quasi nel tempo e che in tanti hanno cercato di rappresentare in diverse forme, dalla musica alle sculture, sino alla letteratura. Pietro Spirito nel suo “Na tazzulella ‘e cafè miti e riti dell’elisir napoletano“, edito da Giannini Editore e disponibile qui a 6 euro, ha voluto esprimere questa tradizione inseguendola nelle sue tappe fino ad arrivare proprio nel capoluogo partenopeo.
Tazzulella, attraverso i porti e i commerci, la bevanda del diavolo si fa strada nei cuori degli italiani
A partire da quando il Papa stesso, Clemente VIII, decretò che fosse lecito per i cristiani consumarlo – prima era soltanto un’abitudine dei musulmani e quindi non vista di buon occhio tra i cattolici -.
Anche il caffè è stato promosso del tutto nello Stivale attraverso un matrimonio a scopi politici e strategici: quello tra il re del Regno di Napoli, Ferdinando di Borbone e Maria carolina d’Austria, grande amante del caffè. Un’unione felice, soprattutto per chi ha potuto finalmente godersi questo rito in pace.
Ecco che la tazzulella arriva a Napoli.
Questa è soltanto una delle storie raccontate dall’autore, che raccoglie aneddoti e leggende attorno alle origini della tazzulella seguendo alcuni personaggi in particolare, come il musicologo Pietro Della Valle.
A partire dal 1800 il caffè napoletano prospera e pianta solide radici nella cultura italiana e napoletana.
Ovviamente non si può parlare di tazzulella senza comprenderne il modo per estrarla correttamente, la scelta della materia prima – non basta l’Arabica, ci vuole un po’ di Robusta per ottenere la cremina iconica – l’uso di un’acqua specifica – si parla di quella proveniente dalle sorgenti cristalline del Serino – il servizio in una tazzina in ceramica, bombata che mantiene bella calda la bevanda e rigorosamente al banco accompagnata da un bicchiere d’acqua.
In questo rito, il barista gioca un ruolo altrettanto fondamentale: nel libro si parla di talento e maestria nel saper usare l’altro caposaldo del caffè napoletano, ovvero la macchina a leva. Ovviamente, parte del fascino della tazzulella è la sua condivisione e qui si inserisce l’altra tradizione sociale, del caffè sospeso.
E un altro volto della tazzulella si lega all’uso domestico della cuccuma, progettata dall’inventore francese Jean-Louis Morize nel 1819. Una moka che funziona però per percolazione e forza di gravità.
Quello che emerge dal testo è in effetti, un amore infinito, quasi viscerale, scritto nel dna e trasmesso di generazione in generazione del popolo partenopeo: “Non c’è napoletano che non sia terrorizzato – quando deve intraprendere un lungo viaggio – dalla idea di affrontare una traversata nel deserto senza poter gustare un autentico caffè napoletano.”
Un prodotto finale che non è possibile ottenere se non con l’incontro di diversi elementi, a partire dalla magia delle 5M – miscela, macinatura, macchina espresso, manutenzione e mano del barista – e 3C – la tazzulella deve essere calda, comoda e carica -. Ecco che nell’incrocio tra queste due formule, nasce il mito della tazzulella.
Una cerimonia, un sentimento, che può essere esplorato con la lettura del libro di Pietro Spirito, magari proprio mentre si sorseggia un espresso a Napoli, perché no.